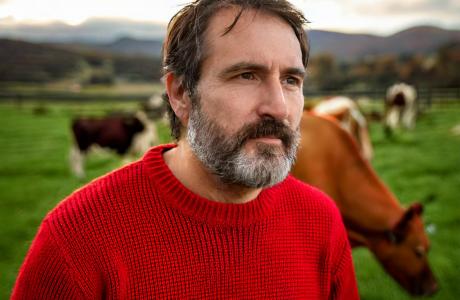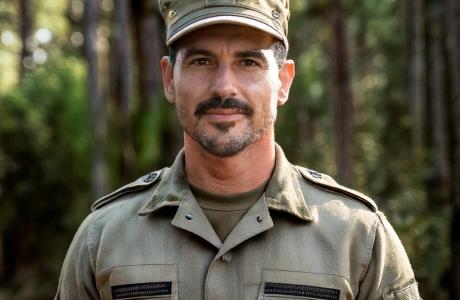Policy positions
Policy position 1
Vivere della natura
La natura può offrire risorse sufficienti per soddisfare i bisogni e i desideri umani. Fornisce tutto ciò che serve alle società umane per sopravvivere e prosperare. In breve, le persone hanno il diritto di utilizzare piante, animali e minerali per sopravvivere e ottenere ciò di cui hanno bisogno, come cibo, vestiti e un riparo.
Policy position 2
Vivere con la natura
La natura non è solo degli esseri umani. I processi e le risorse naturali permettono a tutti gli esseri viventi di soddisfare i propri bisogni. Le persone usano le risorse naturali con attenzione, sono responsabili nei confronti del mondo naturale e agiscono per proteggere l’ambiente. Esseri umani e natura possono prosperare, insieme.
Policy position 3
Vivere nella natura
La natura è composta dalla terra e dai paesaggi. I luoghi naturali sono importanti per le comunità umane e per le loro culture. Un’area naturale contribuisce a plasmare l’identità della comunità umana a essa legata. Le persone vedono sé stesse come parte del mondo naturale e fanno del proprio meglio per mantenere quest’ultimo in salute.
Policy position 4
Vivere come natura
Gli esseri umani fanno parte della natura. Le persone si sentono connesse alla natura in termini fisici, mentali o spirituali. Le persone sono interdipendenti con la natura e capiscono quanto le loro azioni influiscono sull’ambiente naturale. Percepiscono una profonda connessione con animali, piante ed elementi come l’acqua e l’aria.